|
PAOLO
Ho conosciuto il Comandante
Paolo (Alberto Araldi) a Pigazzano, verso la fine di
luglio dell’anno 1944. In Val Trebbia ed in particolare
a Rivergaro se ne parlava da un paio di mesi. Stava
diventando un mito. Anche perché molte famiglie del
paese avevano figli, fratelli, parenti nella brigata
partigiana da lui comandata e che aveva già fatto
parlare di se per alcune azioni contro i tedeschi e le
milizie fasciste che circolavano nella nostra provincia.
Di lui si sapeva che era carabiniere, ufficiale o
sottufficiale e che proveniva dalla Val Tidone.
Carabiniere come il capo dei partigiani di Val Trebbia e
Val Tidone, Fausto e come altri che avevano abbandonato
le loro caserme per non servire i tedeschi ed il
rinascente fascismo.
Mio padre ed io, in un fatidico mattino di fine luglio,
dopo un tentativo di cattura da parte di una squadra
fascista, non so bene se si trattasse di militi della
Guardia Nazionale Repubblicana o delle appena costituite
Brigate Nere, avevamo preso i sentieri che da Rivergaro,
guadato il fiume Trebbia, conducevano a Pigazzano, un
piccolo paese appena sotto il monte Pillerone. Avevamo
con noi pochi indumenti, oggetti di conforto e viveri,
in una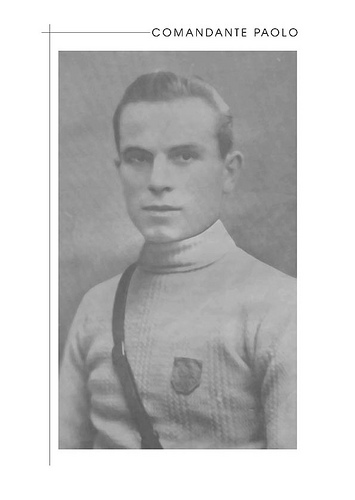 vecchia valigia che io portavo e che mi sbilanciava da
un lato mentre camminavo e raddoppiava la fatica della
salita.
vecchia valigia che io portavo e che mi sbilanciava da
un lato mentre camminavo e raddoppiava la fatica della
salita.
Fortunatamente, a metà strada, ci imbattemmo in un
motocarro con due giovani partigiani a bordo che ci
fecero accomodare sul cassone e ci portarono a Pigazzano.
In quei giorni eravamo certi che la liberazione, con
l’arrivo delle truppe anglo-americane e la discesa dei
nostri dai monti, fosse ormai questione di pochi giorni
o poche settimane. Per questo motivo avevamo portato
così poco con noi e non avevamo idea su dove passare la
notte e su che cosa fare nei giorni successivi.
A Pigazzano una donna ci indirizzò ad una casa appena
sotto la chiesa parrocchiale, dove una sua conoscente
disponeva di una camera. Quest’ultima fu lieta di
metterla a nostra disposizione. Era una piccola camera,
bassa di soffitto, con travetti in legno parzialmente
dipinti di bianco, un letto in ferro con reti mezze
sfondate e materassi pieni di “scartoffie”, le foglie
che ricoprono le pannocchie di granoturco, un piccolo
cassettone , un catino con brocca di metallo smaltato.
Ci sistemammo nella camera e poi uscimmo. Mio padre
chiese di Paolo ad alcuni partigiani di Rivergaro che
conoscevamo bene. Ci indicarono una scaletta che
scendeva dalla strada verso la cantina di una casa. Dal
cortiletto ai piedi della scaletta provenivano grida
rauche e comprendemmo che qualcuno stava strapazzando
qualcun altro. Era Paolo che faceva una violenta
paternale ad un malcapitato seduto su un gradino che
ascoltava a testa bassa. Lo riconobbi. Era un giovane di
Rivergaro che apparteneva ad una nota famiglia di
fascisti: Dicevano in paese che facessero volentieri la
spia a favore dei fascisti, forse non tutti i membri, ma
allora si faceva d’ogni erba un fascio e se era
fascista, o antifascista, il padre dovevano avere le
stesse idee anche i figli eccetera.
Mio padre sapeva, però, che quel giovanotto aveva l’anno
precedente informato il maresciallo dei carabinieri che
in casa mia si ascoltava Radio Londra. Lo sapeva perché
glielo aveva spifferato lo stesso maresciallo, il quale,
qualche mese dopo aveva abbandonato la caserma con i
suoi militi e si era unito ai partigiani di Fausto.
Quel giovanotto se la cavò con la strigliata di Paolo,
anche perché era salito a Pigazzano di propria volontà
per arruolarsi fra i partigiani, ma fu rimandato a casa.
Mi sorpresero la calma ed il sorriso di Paolo dopo la
sfuriata, quando si soffermò a parlare a lungo con mio
padre.
Paolo comandava un distaccamento di un centinaio di
uomini, abbastanza bene armati. Disponevano di una
mitragliatrice da 20 millimetri che aveva sparato alcune
raffiche un paio di settimane prima verso Rivergaro nel
corso di un breve attacco dalla riva sinistra del
Trebbia, nel quale ero stato coinvolto mentre facevo il
bagno nel fiume con alcuni amici in una località
chiamata “Tre alberoni”. Avevano un mortaio da 81
millimetri e stavano addestrandosi ad usarlo. Ciò che mi
colpì fu un grosso binocolo da marina su treppiede di
grande potenza che loro chiamavano “telemetro”. Con quel
binocolo riuscivo a vedere distintamente il giardino di
casa mia a Diara e quello di Savignano dove mi parve di
intravedere la Nena, una mia fiamma giovanile.
Paolo era un bell’uomo, dallo sguardo fiero, sapeva
essere elegante pur nelle ristrettezze degli
equipaggiamenti partigiani e mi fece una grande
impressione. Il distaccamento di Pigazzano, che poi
sarebbe diventato la III Brigata della Divisione
Piacenza, era abbastanza disciplinato, pur annoverando
nei suoi ranghi qualche elemento che non aveva mai fatto
addestramento militare. Lo si vedeva nelle adunate sulla
piazzetta del paese, quando Paolo impartiva gli ordini o
dava qualche lavata di capo. Quasi tutti si tenevano in
riga ed ascoltavano compunti, ma c’era sempre uno che
dava segni d’impazienza o sbuffava rumorosamente. Erano
molto ottimisti e si dichiaravano certi di poter far
fronte, con le loro armi, ad attacchi di autoblindo e
carri armati. Uno di loro mi disse: “Per i carri armati
abbiamo le bottiglie di benzina”. Lo dissi a mio padre
che mi guardò con un sorriso un po’ dubbioso.
Una mattina, verso le 8, arrivò a gran galoppo un
partigiano a cavallo. Saltò a terra ed annunciò al
comandante che i fascisti avevano attaccato Agazzano ed
era in corso una battaglia. Gli uomini furono subito
riuniti e si prepararono alla partenza. Alcuni si misero
in spalla i fucili mitragliatori, altri portavano
cassette di munizioni. La battaglia si svolgeva ad un
paio d’ore di cammino ed il distaccamento non possedeva
ancora mezzi di trasporto. Solo nelle settimane
successive ne ne furono catturati alcuni nel corso di
azioni sulla Via Emilia. Ad un certo punto arrivò un
altro cavaliere che diede il contrordine. Non occorreva
più l’aiuto di Paolo e dei suoi. I fascisti si erano
ritirati.
Passammo a Pigazzano tre giorni. La mattina del quarto
giorno fummo sorpresi da un forte cannoneggiamento che
proveniva dal fondo valle. Mentre facevamo fagotto, una
nutrita fucileria ci indicò che i partigiani stavano
difendendo le loro posizioni al Castello dei Volpi, un
po’ sotto Pigazzano, ma verso mezzogiorno anche loro
dovettero ritirarsi.
Rividi Paolo a San Giorgio di Bobbiano qualche ora dopo
mentre confabulava con Fausto e Sormani ed anche mio
padre si unì a loro. Quando tornò mi disse di prendere
la valigia e ci rimettemmo in cammino, per arrivare dopo
il tramonto nei pressi di Monteventano, ma questa è
un’altra storia.
Quando Rivergaro fu di nuovo occupata dai partigiani, in
settembre, incontrai Paolo, con Fausto, nei pressi di
casa mia, a Diara. Mi guardò e parve che mi
riconoscesse, ma mi chiese: “Tu sei un fratello del
Dottor Giorgio?” Gli risposi di no e gli dissi chi ero.
Allora si ricordò e mi disse di salutare mio padre.
Non l’ho più rivisto. Ero a casa, nel febbraio
successivo, dopo il tragico rastrellamento invernale,
quando si sparse la voce che Paolo era stato catturato a
Piacenza dai fascisti e subito fucilato. La gente
sussurrava la notizia e ne era costernata. Era come se
tutti avessero perduto un figlio, un fratello. La sua
popolarità nella valle era immensa. Ricordavamo le sue
imprese temerarie nelle polveriere di Gossolengo e San
Bonico, sulla via Emilia e nel nostro stesso paese che
una volta, di ritorno da un’azione in pianura, aveva
attraversato a grande velocità in auto sparando raffiche
di mitra contro gli attoniti fascisti sulla piazza
principale.
S’era fatto prendere ad un posto di blocco alla
periferia della città mentre stava per mettere in atto
l’ennesima azione, tradito da una spia.
Molti erano stati i caduti e gli uccisi fra dicembre e
marzo. Le perdite fra i partigiani e fra la popolazione
delle nostre montagne durante il rastrellamento della
Divisione Turkestan e delle milizie fasciste erano state
ingenti, ma la morte di Paolo fu più sentita delle
altre.
Dopo la Liberazione gli fu conferita la medaglia d’oro
al valor militare alla memoria.
Giacomo Morandi -
giugno 2009 |