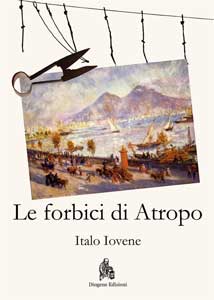Presentiamo un capitolo di un romanzo - "Le forbici di Atropo" - scritto e pubblicato da Italo Iovene e reperibile sul web, anche in formato e book...... Il capitolo si intitola la Comit. La copertina: cliccate sull'immagine sottostante per ingrandirla.
La Comit
Da bambino ero entrato un paio di volte in quel palazzo quando, in occasione dell’ Epifania, la Banca distribuiva doni ai figli dei dipendenti.In ascensore fino all’ultimo piano dove c’era il Cral Comit. Un bell’ambiente, dotato di comode sedie e di un biliardo, dove molti impiegati preferivano trascorrere le due ore di intervallo piuttosto che rientrare a casa per il pranzo.
All’età di 46 anni le condizioni di salute di papà si aggravarono improvvisamente, a seguito della malattia contratta in Etiopia, tanto che gli assegnarono la categoria di grande invalido di guerra con accompagnamento ed incollocabilità al lavoro. Divenni, quindi, equiparato ad un orfano di guerra ed evitai il servizio militare entrando a far parte dei futuri lavoratori a categoria protetta.
In Direzione Centrale a Milano fecero presente a mio padre che, se avesse voluto, avrebbero potuto assumermi: si resero conto delle difficoltà economiche cui sarebbe andato incontro e avevano anche da colmare il vuoto delle “categorie protette” obbligatorio per legge.
Lui non voleva, il suo sogno era di vedermi laureato in giurisprudenza a continuare la professione del nonno avvocato…
Clara, che lo aveva accompagnato, più pragmatica e, conoscendo l’antipatia che provavo per le materie giuridiche, intervenne:
“Telefoniamo a Gennaro e chiediamogli cosa ne pensa”.
“Siiiiiiiiiiiiiiiiiii”, risposi,”si, si, mamma, convinci papà”.
Vestito lavato e stirato, cravatta con i soliti, ed unici, gemelli, mi recai all’Ufficio del Personale della sede di Napoli per sostenere la prova di dattilografia che era l’unico test da superare per gli aspiranti bancari. Fu un disastro! La dettatura fu troppo veloce per me che a stento conoscevo la tastiera e la conclusione fu che non ero adatto per la banca.
Il baroncino si incavolò non poco.
Scrisse allora al Capo del Personale in Direzione Centrale che gli sembrava assurdo giudicare un ragazzo, in possesso di maturità classica ed iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, inidoneo per una prova di dattilografia non andata bene.
Papà conosceva il vero motivo: era totalmente inviso al Capo del personale della Sede di Napoli. Il baroncino era stato assunto dalla Comit a seguito di una potente raccomandazione di un gerarca fascista, conosciuto dalla baronessa, e dopo la caduta del regime aveva continuato a professare le sue idee con forza, caparbietà e mantenendo sempre quel suo modo altero e coraggioso di dire ciò che pensava. Il coraggio non gli era mai mancato, anche quello di dire al Capo del personale che in banca facevano carriera soltanto raccomandati e cornuti (ed era nota una certa predilezione che quel signore aveva per le donne).
La lettera ebbe un effetto immediato. Fui di nuovo chiamato dall’Ufficio del personale dove mi fecero accomodare, dettarono con calma, direi lentamente, tanto che la battitura venne quasi perfetta.
Un mese dopo fui assunto.
Non aveva torto papà, in banca si era assunti solamente se raccomandati da politici, da importanti clienti (Lauro e Signorini imperavano), se generi, nipoti, figli di amici intimi, naturali e di secondo letto, oppure, come me, figli di ex dipendenti, ancor più se di un grado elevato.
Lo stipendio era ottimo, prima busta paga 120 mila lire per 16 mensilità! Mi sentivo un gran signore. Subito due vestiti su misura da un sarto di via Chiaia, la 500 Fiat a rate, ricambio totale di un guardaroba povero, da studentello.
Ma, fino a quando il “nemico” di mio padre imperò nella Filiale di Napoli, fui addetto alla mansione peggiore: l’intera giornata lavorativa dietro l’Audit, un lavoro durissimo. Avevo due grossi cassoni contenenti le schede dei clienti allocate dentro un cartone che chiamavano marsupio, avanti un tavolino con quella macchina infernale che era l’Audit, di fianco un tampone battente, l’adrema, e dei cassetti pieni di moduli, in massima parte i 255, da compilare al momento in cui un’operazione andava a debito o superava la linea di credito messa a disposizione dalla banca (ovvio che tutto era devoluto all’occhio del posizionista, quindi mio, che, a volte, sbagliava incorrendo nelle ire della Direzione).
Mi giravo continuamente a destra e a sinistra per prendere una scheda, estrarla dal marsupio, infilarla nell’Audit, battere il saldo precedente, il codice cliente, l’importo dell’operazione a credito o debito, la causale dell’operazione stessa (assegno, versamento, bonifico) e finalmente dalla macchina usciva il nuovo saldo e, se trattavasi di prelievo, controllare che tutto rientrasse nella disponibilità del correntista.
L’ufficio posizioni era un pò il cuore della banca e anche uno dei primi approcci dove un impiegato novello stazionava generalmente un anno, ovviamente molto meno se raccomandato e destinato ai piani alti.
Rimasi due anni e quando finalmente speravo di poter riposare la schiena dalle continue contorsioni:
“Gennaro B., da domani lei va all’Agenzia 6 a Santa Lucia. Hanno bisogno di un posizionista esperto”.
Lo credo! Dopo due anni ero uno dei più esperti e veloci. Presa per i fondelli perché trascorsero ulteriori due anni.
Ma ero felice e ringraziavo l’Istituto, e l’ho sempre fatto e lo farò ancora. Cosa importava che molti colleghi andassero avanti?
Non giudicavo, pensavo a fare il mio lavoro ed allo stipendio che, rispetto a quello di altri salariati, era veramente eccellente. Mi permetteva una vita comoda, non mi mancava nulla.
Il sabato e la domenica mattina, quando non mi incontravo con Virginia che stava preparando la tesi di laurea, li trascorrevo sul terrazzo della nuova casa al corso Vittorio Emanuele, dove eravamo andati ad abitare. Da una splendida terrazza si godeva il panorama del golfo, era un sogno. Divoravo libri e scrivevo poesie, qualche novella, pensieri in punta di penna.
Oh Erato, perdona l’uomo
che tende a te le proprie mani.
Non posso più pensare
e violo il nome tuo
scrivendo attimi
che non sono miei.
Dimentica le mie povere parole
che hanno soltanto
il sapore dei ricordi,
mandorle amare che non ingoio più.
Dimmelo e finirò,
se frasi senza senso
possono turbare chi sa di poesia.
Volevo scusarmi con la musa, sapevo di non essere un poeta, ma uno
scribacchino. Le volte in cui uscivo, spesso mi recavo a vedere mostre di
pittura in qualche galleria del centro o del Vomero, ne sono rimaste così
poche adesso, sono scomparse quasi tutte. La maggior parte erano vecchie
botteghe di corniciai trasformatisi in mercanti di arte. Non erano studiosi
o critici, ma dei praticoni che vedevano l’autenticità di un quadro a dieci
metri. Conoscevano bene i pittori, la loro tecnica, e ne distinguevano le
pennellate, i colori. Poi c’erano i grandi galleristi, quelli che l’800
napoletano lo avevano nel sangue, ed intorno a loro ronzava una pletora di
ricercatori che procuravano i pezzi migliori. A Napoli operavano molti
pittori cosi detti di maniera, in massima parte epigoni di quella scuola che
aveva avuto come capostipiti Anton Van Pitloo e Giacinto Gigante: la scuola
di Posillipo, ma anche seguaci di Smargiassi, Altamura, la pittura
accademica. Non avevano attecchito ancora le nuove tendenze pittoriche
provenienti da oltre oceano. Qualche giovane artista, uscito dall’Accademia,
cercava di seguire le nuove tendenze, ma il mercato napoletano richiedeva
quel tipo di pittura ed il mercato in arte ha sempre creato l’artista, anche
se spesso soltanto del momento. Il Gennarino universitario, spensierato,
sbarazzino, profondamente ironico che quando parlava di se stesso diceva:
sinceramente confuso, draconianamente drastico, esteticamente allibito,
umanamente perplesso, gioiosamente ilare, quantitativamente povero,
culturalmente incolto, spettacolarmente spettacolare, amichevolmente
indeciso, eternamente finito, infinitamente semplice, anche se l’apparenza
inganna, cedeva il passo al pragmatismo della vita e, nel mondo in cui ero
entrato, mi resi conto che l’apparenza era tutto. Lì, dove con la promozione
nella categoria funzionari lo stipendio raddoppiava, apparire contava molto
più che essere, come un pò in tutto il mondo del lavoro dipendente, ma,
calato in quella realtà, all’inizio stentai ad adeguarmi. Trovai tra i
colleghi rappresentata tutta la gamma dell’umana specie e non sempre i
migliori proseguirono nella carriera. Non mi consideravo un migliore,
soprattutto in un lavoro che non amavo, pur rispettandolo perché mi
permetteva di vivere meglio di tanti della mia età. Sapevo di essere un
normale, uno dei tanti che affollavano la Comit in quegli anni. Tranne
veramente pochi, che stento anche oggi a ricordare, non conobbi mai
personalità carismatiche nell’Istituto, anche nei piani alti: uomini, ometti
e qualche quaquaraqua. Il lecchinaggio era quasi obbligatorio, a tutti i
livelli, dal capo ufficio ai massimi gradi. Spesso si lavorava oltre
l’orario contrattuale con il “dono” di mezz’ora di straordinario, molto meno
di quanto effettivamente sarebbe spettato. Il baroncino mi aveva
catechizzato, ma non disperavo, perché nella vita a volte…universitario,
spensierato, sbarazzino, profondamente ironico che quando parlava di se
stesso diceva: sinceramente confuso, draconianamente drastico, esteticamente
allibito, umanamente perplesso, gioiosamente ilare, quantitativamente
povero, culturalmente incolto, spettacolarmente spettacolare, amichevolmente
indeciso, eternamente finito, infinitamente semplice, anche se l’apparenza
inganna, cedeva il passo al pragmatismo della vita e, nel mondo in cui ero
entrato, mi resi conto che l’apparenza era tutto. Lì, dove con la promozione
nella categoria funzionari lo stipendio raddoppiava, apparire contava molto
più che essere, come un pò in tutto il mondo del lavoro dipendente, ma,
calato in quella realtà, all’inizio stentai ad adeguarmi. Trovai tra i
colleghi rappresentata tutta la gamma dell’umana specie e non sempre i
migliori proseguirono nella carriera. Non mi consideravo un migliore,
soprattutto in un lavoro che non amavo, pur rispettandolo perché mi
permetteva di vivere meglio di tanti della mia età. Sapevo di essere un
normale, uno dei tanti che affollavano la Comit in quegli anni. Tranne
veramente pochi, che stento anche oggi a ricordare, non conobbi mai
personalità carismatiche nell’Istituto, anche nei piani alti: uomini, ometti
e qualche quaquaraqua. Il lecchinaggio era quasi obbligatorio, a tutti i
livelli, dal capo ufficio ai massimi gradi. Spesso si lavorava oltre
l’orario contrattuale con il “dono” di mezz’ora di straordinario, molto meno
di quanto effettivamente sarebbe spettato. Il baroncino mi aveva
catechizzato, ma non disperavo, perché nella vita a volte…
Italo Iovene
 Due mondi - quello algido e cristallino dell'Olimpo e quello caotico, multiforme, onnivoro, violento eppur meraviglioso della nostra Napoli - si fondono e si compenetrano in una dimensione dove quegli stessi dei che nella letteratura classica partecipano alle vicende umane senza che sia mai intaccata la loro aurea serenità vedono il loro ruolo pericolosamente messo in discussione. Italo Iovene ci introduce sapientemente ad un nuovo, inedito "sentimento" divino: la preoccupazione, la consapevolezza della fragilità della propria posizione, un sottile senso di disagio ed inadeguatezza che si fa strada nella percezione di un ruolo che non è più stabile e immutabile ma suscettibile di crisi dirompenti. E così gli dei dell'olimpo vacillano, sono costretti ad immergersi in una realtà multiforme e pulsante spinti da una profonda e consapevole preoccupazione per il proprio destino.
Due mondi - quello algido e cristallino dell'Olimpo e quello caotico, multiforme, onnivoro, violento eppur meraviglioso della nostra Napoli - si fondono e si compenetrano in una dimensione dove quegli stessi dei che nella letteratura classica partecipano alle vicende umane senza che sia mai intaccata la loro aurea serenità vedono il loro ruolo pericolosamente messo in discussione. Italo Iovene ci introduce sapientemente ad un nuovo, inedito "sentimento" divino: la preoccupazione, la consapevolezza della fragilità della propria posizione, un sottile senso di disagio ed inadeguatezza che si fa strada nella percezione di un ruolo che non è più stabile e immutabile ma suscettibile di crisi dirompenti. E così gli dei dell'olimpo vacillano, sono costretti ad immergersi in una realtà multiforme e pulsante spinti da una profonda e consapevole preoccupazione per il proprio destino.
Nella mitologia greca, Atropo (in greco: Ἄτροπος, cioè in nessun modo,
l'immutabile, l'inevitabile) era una delle tre Moire (o Parche, nella
mitologia romana), figlia, secondo una versione, della Notte o, secondo
un'altra, di Zeus e di Temi (o Mnemosine). Atropo, la più anziana (Esiodo,
Scudo, 259: ... Atropo, non era una grande dea, ma certamente alle altre
superiore e più anziana...) delle tre sorelle, è colei che non si può
evitare, l'inflessibile; rappresenta il destino finale della morte d'ogni
individuo poiché a lei era assegnato il compito di recidere, con lucide
cesoie, il filo che rappresentava la vita del singolo, decretandone il
momento della morte.
ITALO IOVENE è nato a Napoli. Ha frequentato il liceo Vittorio Emanuele II e poi la Facoltà Federiciana, laureandosi in Giurisprudenza. Ha lavorato nelle Banca Commerciale Italiana dove ha operato per 32 anni. Da otto anni fa parte della Compagnia teatrale Cangiani diretta da Lucio Monaco.
|
Piazza Scala - febbraio 2015